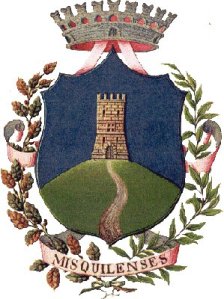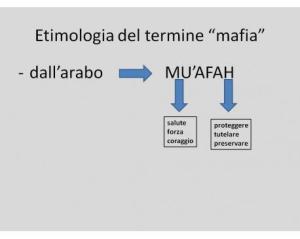Le notizie di stragi compiute dai «liberatori» francesi duecento anni fa iniziano a filtrare e s’incrina così il muro di silenzio, anzi la drastica torsione valutativa imposta dai libri di scuola sulla prolungata presenza nella Penisola — dal 1792, tempo della guerra tra Francia repubblicana e monarchia sabauda, al 1814 quando gli austro-russi dilagano nella valle Padana dopo la caduta di Napoleone I — delle truppe napoleoniche. Nel Mezzogiorno questa riscoperta si caratterizza come meno sporadica — il numero di episodi che riaffiorano è elevato — e più massiccia — il numero delle vittime e l’efferatezza degli episodi. Su quanto accaduto nella parte settentrionale del paese, viceversa, pare non sia accaduto nulla di questo genere. Tuttavia anche qui, anche se a goccia a goccia, qualcosa comincia a emergere.
Ne fa fede un piccolo — ma quando c’è di mezzo un eccidio si può parlare di piccolo o grande? — episodio che è stato scoperto in Veneto da uno storico locale nel ricostruire i lineamenti storici dell’occupazione militare francese della provincia trevigiana nel 1797, negli ultimi mesi della Repubblica di Venezia.
Il 2 febbraio di quell’anno, a Mussolente, villaggio che conta oggi poco più di settemila abitanti, a sei chilometri da Bassano del Grappa, cinque poveri contadini — Andrea Polo, Sguardo Polo, Francesco Guadagnin, Giuseppe Fontana, Baldissera Orso — sono fucilati «sul posto» da un reparto francese dell’armata del generale André Masséna, in ritirata dalla Valsugana — dopo il ciclo di battaglie del gennaio precedente, passate alla storia con il nome di Rivoli Veronese —, perché hanno tentato di difendere il raccolto, le bestie, i viveri di cui i rapaci soldati d’Oltralpe volevano appropriarsi con la forza. Un episodio passato del tutto nel dimenticatoio e solo oggi, grazie alla solerzia della preziosa storiografia locale — quella, magari, come in questo caso, formata da storici, de facto anche se non nelle doti spesso di prim’ordine, «della domenica» — riemerso alla luce e che ci interpella.
Dunque, una strage gratuita, un atto di brutalità finalizzato a terrorizzare le popolazioni contadine italiane — di cui peraltro Bonaparte ebbe sempre, e a ragione, paura — di allora e ad asseverare il presunto diritto delle truppe «liberatrici» di estorcere a loro piacimento beni ai loro proprietari terrieri e ai loro poveri intendenti in loco — si badi bene: appartenenti a uno Stato dichiaratosi neutrale, con cui di conseguenza la Francia non era in regime di belligeranza.
Mi domando: quanti altri sfregi del genere le nostre popolazioni hanno dovuto subire in quegli anni? Si è parlato nei mesi scorsi di un «armadio della vergogna», in relazione alla scoperta di un archivio in cui sono stati — per alcuni colpevolmente, per altri doverosamente — sepolti per decenni i dossier penali relativi a stragi compiute da soldati italiani nei Paesi occupati, in specie nei Balcani, rimase quindi impunite. Quantidossier dovrebbe contenere un «armadio della vergogna» dedicato a queste stragi, che vedono coinvolti i nostri antenati, ma non per questo sono state meno reali e dolorose? Non si può non osservare che, se di alcuni eccidi compiuti nel secondo conflitto mondiale — da tedeschi, truppe italiane, milizie fasciste o partigiani — quanto meno esiste undossier, magari sepolto dalla polvere, perché qualcuno si è almeno mostrato interessato a punirne i colpevoli, degli eccidi del periodo napoleonico la memoria si è letteralmente dissolta.
Ma — continuo a domandare — in che misura l’imbarbarimento della guerra, dovuto al coinvolgimento dei civili che i francesi «emancipati» attuano, non creerà un precedente, che autorizzerà anche altri eserciti a imitare i «novatori» di Oltralpe? Una liberazione al tal prezzo è una liberazione moralmente accettabile da un popolo — e la grande stagione dell’Insorgenza è lì testimoniarne il rifiuto — e da chi ne deve rappresentare in esplicito i valori, cioè i poteri pubblici? O, almeno, è lecito parlare ancora in termini encomiastici, se non elegiaci, di un ventennio di rapporti tra Francia rivoluzionaria e napoleonica e Italia, che si configura in termini di un assoggettamento totale e di una violenza ancora tutte da narrare, perpetrate dalla consorella transalpina contro i popoli della Penisola? E, da ultimo, è segnale di equità di giudizio dilatare in maniera abnorme, solo perché più recenti e di segno ideologico più gradito, la memoria delle stragi compiute in Italia dalle truppe hitleriane, quasi sempre rappresaglie, dopo l’8 settembre 1943? Perché non parlare invece di due — di tante — occupazioni, entrambe drammatiche e foriere di gravi lesioni e ricadute fatali sulla condizione morale della nazione italiana?
Si discute oggi tanto di memoria condivisa: non so se sia un traguardo raggiungibile, anche perché manca una definizione «condivisa» di che cosa sia tale memoria… Di certo, però, il primo passo in questo senso che occorre fare è sul piano dei fatti, non mutilando la memoria. Bisogna quindi ammettere che l’Italia ha subito sanguinose rappresaglie da parte degli sconfitti dell’ultima guerra mondiale, ma ha anche patito tanti scempi inflittile da troppi «liberatori», e fra questi non si possono non annoverare i rivoluzionari francesi e Napoleone.
Solo in questo orizzonte davanti sarà possibile riconquistare una parte di verità sulla storia d’Italia e, quindi, acquisire una più matura consapevolezza di chi siamo e di dove andiamo come popolo.
* * *
Do di seguito le pezze d’appoggio della mia argomentazione, di cui sono debitore al signor Millo Bozzolan di Seren del Grappa (Belluno), il quale, a sua volta ha avuto notizia dei fatti dal dott. Giorgio Zoccoletto, rinomato storico veneto, autore, fra l’altro, di 1797. L’occupazione napoleonica del territorio trevigiano (Antilia, Treviso 1997). Si tratta (a) di una lettera informativa inviata da Bozzolan al quotidiano Il Gazzettino di Venezia; (b) del testo della denuncia fatta dal capo della comunità di Mussolente al pretore di Asolo (Treviso), nonché (c) della comunicazione di costui al podestà di Asolo Zustinian Badoer (entrambi i documenti si trovano in Archivio Di Stato Di Venezia, Senato Militar Terra Ferma, filza 38).
Fonte: https://venetostoria.com/