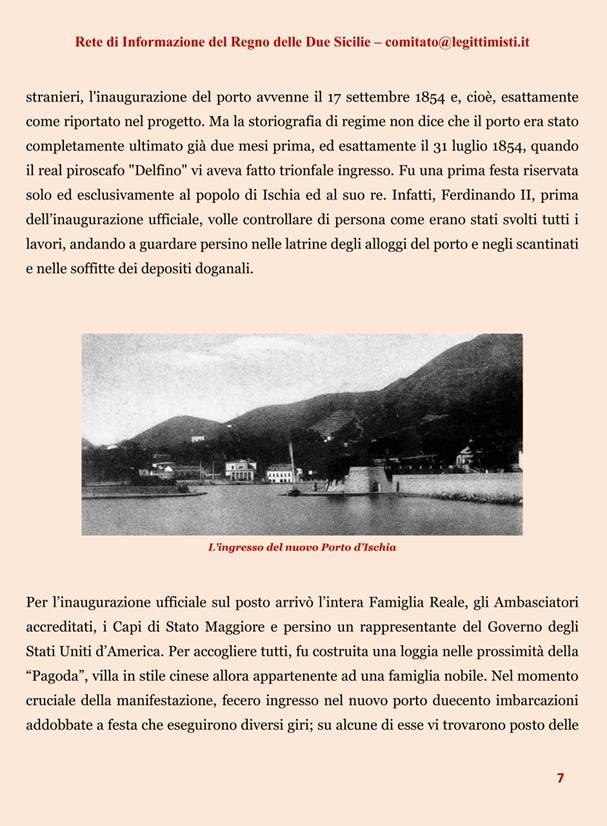Qualche sera fa, chiacchierando con un'amica sulla situazione di Trieste e del suo territorio, abbiamo toccato, tra i vari argomenti, lo scomodo... tema dell'italianizzazione forzata compiuto dalle forze di occupazione dell'esercito dei Savoia prima, e dal regime fascista nel periodo immediatamente successivo. Quando si parla di questo, molto spesso si rischia di cadere nella facile retorica, sia in una direzione, che nell'altra, sia ben chiaro, quindi, dico io, bisogna muoversi con i piedi ben foderati da calzature di piombo spesso tre, se non quattro dita. L'argomento è scottante e molto delicato, me ne rendo conto e quando osservo che le reazioni di chi si schiera apertamente dalla parte del tricolore, rasentano la fede più cieca, capisco che il lento lavorare ai fianchi delle istituzioni è stato oltremodo efficace, compiuto con un'intelligenza tale, che mi vien da pensare che se le energie impiegate per questo compito fossero state spese verso altre direzioni, magari per qualcosa di socialmente più utile, forse la situazione in questo strano paese stivaliforme bagnato dal Mediterraneo e baciato dal sole, sarebbe senza dubbio migliore e più stabile. Ma che ci si potrà mai fare? Mi chiedo subito dopo. Così è stato e non si può certamente tornare indietro. Da parte nostra, diciamo da parte degli storici, si può soltanto tentare di raccogliere i cocci che affiorano malamente, ben nascosti tra le strade cittadine, tra palazzi, piazze e giardini e dentro a quello che rimane della nostra memoria collettiva, e provare a sigillarli strettamente fra loro, sperando di non lasciarne fuori neanche uno. Un compito arduo, mi scappa da pensare, scuotendo la testa, quando a volte la sera, immerso nei documenti ingialliti che caparbiamente continuo a raccogliere, faccio il resoconto delle giornata trascorsa. A volte invece tutto sembra chiaro e logico e allora l'ottimismo prende superbamente il posto dei pensieri neri e tutto mi sembra possibile.
Dicevo della chiacchierata dell'altra sera. Tra le varie cose dette, ad un certo punto mi scappa una parola, un termine forse, a parere della mia amica, improprio, forse non usato a proposito. Etnocidio. Il punto è capire se effettivamente mi sia scappato al di fuori da ogni senso del reale, oppure, se in qualche modo, l'operazione compiuta di cui dicevo prima, possa invece rientrare nella logica legata al termine in questione, appunto. Ora, non posso pretendere che nelle poche righe che seguiranno riuscirò a svelare, come si dice, l'arcano, però, partendo dal presupposto che quando si entra in una discussione, lo si deve fare essenzialmente supportati da fatti, io credo di non essere stato in torto quando ho tirato fuori, dapprima timidamente, lo ammetto, ma poi sempre con più convinzione questa parola. Vediamo perché:
Tema piuttosto scottante, come dicevo, quello dell'etnocidio. Scottante e scomodo, aggiungerei. Perché è proprio nell'ottica di chi lo applica sistematicamente che la negazione della sua esistenza diventa a sua volta una costante affermazione della sua realtà effettiva e metterlo alla luce del sole porta con sé, come conseguenza, un grosso rischio: l'essere umano colpito da questo subdolo lavaggio del cervello, fino a quel momento inconsapevole vittima del sistema che lo mette in atto, rischia di trasformarsi in un feroce nemico dello status quo. Voglio spiegarmi meglio e per farlo cercherò di rendere chiaro cosa si intenda effettivamente per etnocidio. Secondo l'antropologo Pierre Clastres, l'etnocidio è la distruzione sistematica dei modi di vita e di pensiero differenti ai quali viene imposta la distruzione. Abbastanza chiaro direi, ma non è tutto. Il dizionario Treccani ne dà una versione leggermente più precisa: forma di acculturazione forzata, imposta da una società dominante a una più debole, la quale in tal modo vede rapidamente crollare i valori sociali e morali tipici della propria cultura e perde, alla fine, la propria identità e unità. La perde a tal punto, aggiungo, che in molti casi si assiste a una negazione violenta delle proprie origini e quasi in una sorta di sindrome di Stoccolma, le persone vittime dell'etnocidio possono manifestare sentimenti positivi (in alcuni casi anche fino all'innamoramento) nei confronti di chi l'ha messa in atto. Curiosa la mente umana, no? È molto interessante assistere a come il cervello, nel tentativo di preservare dalla distruzione l'intero organismo, metta in atto delle strategie di autodifesa che in qualche modo efficacemente lo mettono ai ripari.
Torniamo a noi. Quando si parla di genocidio non ci può essere alcun dubbio. Ce ne sono stati tantissimi, il più tristemente noto dei quali è senza dubbio quello ai danni degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, ma non solo. Pensiamo al popolo armeno, quasi distrutto dai turchi, o a quello dei tutsi in Ruanda negli anni novanta. Insomma, è talmente evidente, che sembra quasi inutile discuterne. Ci sono le prove e se non sono così lampanti è perché sono ben celate, ma prima o poi vengono fuori. È matematico. L'etnocidio è più subdolo e meno evidente. Più nascosto, mascherato. Se il genocidio è un infarto, quindi, l'etnocidio è un cancro che lentamente si espande e non ti lascia scampo. È un lento lavorio ai fianchi di chi, per un motivo o per l'altro, non è in grado di opporre resistenza, di difendersi, o perché non in possesso di sufficienti strumenti culturali, o perché, come nel nostro caso, stremati da anni tremendi, di distruzione totale a seguito di una guerra assurda, ci si muoveva a tentoni, orfani di un mondo dissolto, in una città che era diventata la triste imitazione di se stessa, nella flebile speranza che una nuova paternità avrebbe potuto riportarci agli splendori di un tempo, così vicino in termini temporali, ma talmente tanto lontano per altri versi, da sembrare irraggiungibile. Una città svuotata della sua gioventù, una città che assisteva impotente all'abbandono di chi, in preda a paure spesso motivate, si rifugiava nei territori più interni di quello che aveva rappresentato forse il primo tentativo moderno di superamento dei confini mentali legati all'idea nazionale che tanto prepotentemente era esploso invece in quei tremendi cinque anni di follia collettiva e che sarebbe proseguito poi, con alterne vicende per tutto il ventesimo secolo. Se di una cosa sono assolutamente certo è che l'idea nazionale è stato la peggior maledizione che poteva capitarci. E nel nome dell'idea nazionale che nei nostri territori e nella nostra città prende piede questo sistematico lavaggio del cervello, che io, forse ingenuamente e fuori luogo, definisco oggi etnocidio.
Il piano è semplice. Di una semplicità disarmante da sembrare quasi ovvio. Secondo uno schema orwelliano, si agisce sulla memoria collettiva, trasformandola. Come? Innanzitutto bisogna negare qualsiasi appartenenza a etnie che non siano quella ufficialmente riconosciute e gradite. Nel caso specifico, quella italiana. Quindi: esaltazione dello spirito latino, incensandone nomi e figure (che assumono spesso la valenza di eroi), storia e tradizioni che inevitabilmente vengono precedute dai sostantivi “sacro, sacra, sacri, sacre” e quando si parla di sacralità c'è veramente poco da scherzare. Davanti a questo termine ci si può solo inchinare ossequiosamente e nella più totale commozione. Ed ecco che figure, che in altri tempi verrebbero accomunate a quelle di terroristi, si ammantano della sacralità (ancora!) legata al sacrificio estremo. Quello compiuto per la Patria (sacra, ovviamente) ed ecco che Willhelm Oberdank, ad esempio, diventa Guglielmo Oberdan, e da anarchico, quale, secondo alcune fonti, in effetti era, si trasforma ufficialmente nel più celebre martire immolatosi per l'italianità di queste terre.
Come si può manipolare dati e fatti, con estrema facilità, vero? Ma tutto questo rientra nelle modalità proprie dell'etnocidio, di cui questo è soltanto uno dei tanti sistemi di aggressione dell'organismo. In realtà bisogna attaccare su più fronti. Ovviamente accanto a questa creazione di figure eroiche, che devono diventare un simbolo nella memoria di tutti, si procede anche in altre direzioni, naturalmente tutte collegate fra loro, perché la parola d'ordine è negazione della realtà effettiva e costruzione obbligatoria di una realtà fittizia che sostituisca in breve la prima. Quindi: cambio forzato dei nomi propri e dei cognomi originari non di origine italiana. Mi sembra evidente. Togli le radici a un albero e questo in breve crolla, a meno che... a meno che una bella pianta rampicante lo sostenga e gli fornisca una parvenza vitale. Se poi al suo interno l'albero è morto, poco male. Si tratta solo di un effetto collaterale di poco conto. Ciò che conta è che l'albero, prima di morire, sparga i suoi semi al suolo e che nuove piantine possano crescere belle forti e inconsapevoli. È curioso notare come, peraltro, i primi cambi di cognome effettuati già dal 1919 utilizzino una legge austriaca del 1826 non ancora cancellata, che prevede la modifica del cognome su richiesta dell'interessato. Nel 1923 le cose cambiano. Via le leggi austriache ancora in vigore nei nostri territori e spazio a quelle italiane che ad esempio prevedono anch'esse il cambiamento di cognome a richiesta, con la piccola differenza che se prima erano gratuite, adesso va pagata una tassa. Nel 1926 si cambia ancora e vengono istituite norme speciali per la restituzione e la riduzione alla forma italiana gratuita dei cognomi.
Ora non vorrei dilungarmi troppo su questo aspetto del concetto di etnocidio, rimandandovi piuttosto al testo fondamentale di Paolo Parovel “l'Identità Cancellata” che prende in esame la questione sotto vari aspetti, fornendo inoltre un'accurata lista di cognomi “trasformati” che per il numero che raggiunge fa veramente spavento. Qui si parla di circa centomila abitanti che hanno visto il loro cognome subire un'italianizzazione, o sotto forma di semplice traduzione dalla lingua originaria, o per mezzo di fantasiose assonanze. Ma di questo non voglio parlar oltre. Sappiate soltanto che tutto ciò non è una fantasia notturna ma sono dati reali debitamente raccolti negli archivi o nelle gazzette ufficiali del periodo. Uno degli altri subdoli aspetti dell'etnocidio compiuto ai nostri danni è quello della trasformazione dei toponimi. E qui i nostri sentiti ringraziamenti vanno, tra gli altri, alla nobile e tanto decantata Società Alpina delle Giulia, ai tempi Società degli Alpinisti Triestini, che pensa bene di mutare i nomi di paesi, fiumi, laghi, eccetera eccetera, trasformando i nomi originali, nella cartografia fornita tramite il Touring Club Italiano, in altri, anche molto belli, lo ammetto, ma assolutamente improbabili, di chiara matrice italiana. Poi naturalmente le cose vanno avanti e il tutto diventa ufficiale e ci pensa il Regio Istituto Geografico Militare a sistemare una volta per tutte le cose e così, che ne so, Stanjel diventa San Daniele del Carso, Dolina, San Dorligo della Valle e Boljunz, Bagnoli della Rosandra.
E quindi il lavaggio del cervello procede spedito. Sempre dritto senza ripensamenti. E così si chiudono le scuole tedesche e quelle slovene e quelle croate e diventa proibito esprimersi nei luoghi pubblichi utilizzando la “barbara” lingua s'ciava. E si sa, gente tranquilla non vuole storie. E la gente tranquilla, che pensa a lavorare e a passare il tempo rimanente con la propria famiglia, fa presto ad adattarsi alla situazione e allora tutti alle scuole statali italiane, scuole nelle quali, naturalmente i bambini inconsapevoli vengono bombardati da nozioni assolutamente fuorvianti rispetto alla realtà effettiva e alla storia del loro padri e dei loro nonni al punto tale che i nemici della Patria risultano alla fine essere gli stessi che alla sera i bambini si ritrovano in casa. Gli stessi nonni e padri che fra loro barbaramente si esprimono in questo strano idioma pieno di consonanti. E intanto che il tempo passa, le convinzioni di questi giovani cervelli si fanno sempre più profonde. A scuola si cantano i canti che narrano le gesta di questi eroi immolatisi per la Patria, gli eroi del Piave, Pietro Micca, Maroncelli, i fratelli Bandiera. È tutto un flusso inarrestabile di retorica che viene sparsa a piene mani da questi maestri giunti da terre lontane che hanno sostituito in tempi brevissimi, quegli altri, quelli di prima, e che ora sono a pieno titolo i veri portatori del messaggio identitaria nazionale. Nel corso degli anni tutto questo diventa ordinaria amministrazione e nessuno ci pensa più. Operazione perfettamente riuscita. E intanto che i vecchi se ne vanno e i giovani diventano vecchi a loro volta, preparandosi ad andare per lasciare il posto ai nuovi giovani, tutto questo sembra non avere più alcuna importanza. Le fiabe raccontate sono ormai diventate realtà e tutto si è compiuto. La spugna è passata sul volto del tempo e l'ha trasfigurato.
Questo in definitiva è il senso dell'etnocidio, come scrivevo prima un cancro che si insinua lentamente, giorno dopo giorno, anno dopo anno, ma la conoscenza è alla nostra portata. Non scordiamolo mai. Abbiamo tutti gli strumenti a disposizione per ritrovare una volta ancora il senso delle cose. Il senso della nostra realtà. Sta a noi e soltanto a noi far scattare i meccanismi di difesa, gli anticorpi che ci salveranno la vita, che ci rimetteranno a posto con il nostro passato colpevolmente sepolto e celato una volta per tutte.